| Dialetto, lingua
e letteratura nella prosa di Filippini
La ristampa annunciata delle due maggiori
opere narrative di Felice Filippini è innanzitutto
motivo di soddisfazione per gli interessati che da lungo tempo
desideravano acquisirle alla propria biblioteca personale;
ma è anche occasione ed invito a tornare alla prosa
di questo notevole artista, dotato di un'energia di rappresentazione
e di un agio di scrittura certo non comuni nel piccolo mondo
letterario della Svizzera italiana. Tanto più che la
sua attività di autore creativo, presto surrogata dall'esercizio
quasi esclusivo della pittura, si concentra nello stretto
giro di anni che vanno dalla revelazione del Signore dei poveri
morti (Bellinzona 1943) alla sua ristampa italiana (Firenze
1955). Tra queste due date si colloca, tra altre prove più
brevi, la composizione e pubblicazione della sua prosa d'invenzione
di gran lunga più impegnativa, il copiosissimo Ragno
di sera, che ritrae una piccola comunità paesana nel
momento traumatico di un cataclisma naturalementre il romanzo
d'esordio era costruito attorno al trauma individuale di una
morte infantile accidentale, biograficamente esperito dall'autore.
La scrittura di Filippini ha anche
una fisionomia linguistica molto ben individuata e riconoscibile,
in quanto fortemente influenzata dall'ambiente dialettofono
in cui egli è cresciuto e in cui fa muovere i personaggi
e le vicende narrate. Non però il parlato che, per
fare l'esempio attuale di un'autrice di successo come Laura
Pariani, irrompe tale e quale sulla pagina anche nella forma
originale, ma un dialetto sistematicamente travestito in lingua,
da ricostruire in base al calco e ai suoi adattamenti, Né
il riconoscimento è sempre agevole, se per un termine
come arricciato (Nel Ragno di sera) sarà necessario
scavalcare l'omografo di senso magari contiguo ma diverso,
per raggiungere l'arisciada o risciada dialettale, che significa
propriamente "acciottolato". In Filippini, la materia
verbale, pur globalmente ammantata di italianno, rimane cioè
ancorata al parlato più terragno, tanto da far esclamare
ai lettori di oltre confine dell'epoca. "Ma che italiano
scrive quest'uomo!". A un nativo della nostra terra,
invece, per quanto coperti dai colori della lingua, i contorni
della sinopia dialettale balzano all'occhio sin dalle primissime
battute del primo romanzo con tratti assolutamente motivati:
È ben qui... che abita Ilario Dellamonica di Pietro
? chiede lo scultore Battista alla famiglia riunita in casa
dopo cena, riprendendo con struttura appena sfumata il ticinesismo
e lombardismo comune "L'è be' chi che..."
; e poco dopo, il bocca alla madre : ce n'è ancora
così del tempo (poi corretto, sopprimendo così),
che ricalca il modulo nostrano, pure assai diffuso : gh'è
n'è ancamò iscì... e ancora, sempre nella
pronuncia della madre : devo vederne ancora di cose ("devi
vedenn ancamò da ropp!"). Ma la riposta filigrana
del dialetto traspare, si può dire, ad ogni riga e
pagina, a cominciare dalle sue forme più caratteristiche
ed esposte: si pensi alla giunzione di verbo + avverbio con
l'eventuale aggiunta di preposizioni, a cui la lingua popolare
ricorre frequentissimamente per sopperire alla propria congenita
povertà in certi settori del lessico, oppure per riprodurre
analogicamente un modulo già cristallizzato. Nella
scrittura narrativa di Filippini, questo tipo di formazione
coincide spesso con espressioni chiaramente indiziate : avanzar
fuori o avanzar su per "sporgere", far venir su
l'anima a gnocchetti per "irritare", "creare
disagio" o persino "torturare psicologicamente";
farlo saltar fuori per "ritrovarlo"; camminavano
per in giù per "scendevano". Una realizzazione
estrema di questo fenomeno è nell'espressione rivolta
a Battista dallo stesso padrone di casa, Ilario: una qualche
donna giù di lì per Lugano, poi ridimensionata,
perché già sufficientemente marcata, in una
qualche donna giù per Lugano: traduzione adattamento
del modulo pesantemente dialettale "ona quai dona, gió
[da lì] par Lugan". Sono procedure di ricalco
che ricordano assai da vicino certi passi memorabili dei Promessi
sposi, a cui il maggior filologo di questo secolo, Gianfranco
Contini, ha felicemente applicato la formula di "parole
vestite di cenci fiorentini e impastate di sostanza lombarda":
e l'esempio paradigmatico è nella frase La c'è
la Provvidenza che è sì un "toscanismo"
segnalato, ma anche contemporanea rappresentazione del modo
ben lombardo la gh'è. In Manzoni, s'intende, la colorazione
vernacolare non è mai particolarmente sgargiante, mentre
il realismo violento di Filippini si muove entro una pasta
linguistica che ammette anche l'idiotismo più smaccato
e gergale, secondo una proporzione e una distribuzione mirate.
Di fatto, queste variabilità d'uso sono quasi sempre
funzione del personaggio a cui il narratore cede la parola,
perché, come ha insegnato Pier Vincenzo Mengaldo nello
studio recente sul Nievo narratore, in un testo creativo il
problema della lingua è anche - e a volte soprattutto
- un problema di "voce". In Filippini, la distribuzione
dei dialettalismi più evidenti avviene secondo una
gerarchia che si chiarisce ulteriormente, ponendo in relazione
il parlato con lo statuto dei singoli personaggi, oltre che
con la lingua del narratore. Schematicamente : dal punto di
vista qualitativo, nel Signore si dà molto più
dialetto nel discorso del padre e in quello di Battista e
dei suoi amici, meno, e sia pure con alcuni notevoli scarti,
in quello della madre e del protagonista, narrato e narratore,
Marcellino, Nel Ragno, invece, la diffusa dialettalità
del dettato andrà collegata anche all'uso del discorso
indiretto libero. È una fenomenologia governata dalle
esigenze della rappresentazione artistica, a illustrare le
quali serve porsi sull'osservatorio privilegiato delle correzioni
apportate dall'autore sulle stampe successive dei propri scritti,
da cui è possibile ricavare un quadro piuttosto eloquente.
Va infatti ricordato che, da un'edizione all'altra dei propri
romanzi, parziale o totale che fosse, l'autore è andato
ritoccandone il dettato, di modo che tra la prima, seconda
e ultima versione corrono spesso differenze molto sensibili.
Il confronto è già stato parzialmente operato
e fatto oggetto di riflessione alcuni anni fa, da parte di
Giovanni Bonalumi, in margine al lungo saggio sulla struttura
e scrittura del primo libro di Filippini. Il critico vi aveva
rilevato "una sessantina almeno di interventi" e,
una volta passati al vaglio quelli che gli erano parsi più
significativi - meno di venti - ne aveva concluso (ma sono
osservazioni rapide, relegate in una nota) che ben pochi di
essi apparivano esteticamente motivati. Allo stesso modo,
Guido Calgari, molti anni prima, aveva preso in considerazione
la lingua del Ragno di sera in una stesura provvisoria, stilando
un nutrito "drappello" di quelli che egli considerava
tratti tipici filippiniani, senza però preoccuparsi
di riscontrarlo con la versione andata a stampa del frattempo,
né di vagliare la distribuzione dei dialettalismi rispetto
alle voci dei personaggi o del narratore. E, anche in quel
caso, il bilancio era stato più giudicativo che giustificativo
dell'impiego di determinati arfitici entro la colata verbale
del lunghissimo romanzo. Oggi, disponendo di un materiale
esaustivo per tutte le stampe, siamo in grado di appoggiare
le valutazioni puntuali alla realtà e all'effettiva
dinamica del testo e prospettare le diverse possibilità
di uso - confermate proprio anche dalle correzione d'autore
-, a seconda dell'impiego che lo scrittore fa del mezzo linguistico
per soddisfare esigenze estetiche, oppure meramente strumentali.
Qui potremo darne soltanto un'illustrazione rapsodica. Intanto,
si danno correzioni puntuali e sistematiche che interessano
le preposizioni articolate (colle diventa con le ; colla >
con la), oppure il tipo riescire, ritoccato in riuscire (così
come cotidiana > quotidiana, traverso > attraverso)
e che documentano il passaggio da paradigmi scolastici conservativi
molto resistenti in una zona periferica come il Ticino, almeno
fino alla fine della guerra, a una veste più moderna.
In secondo luogo, i regionalismi che nella ristampa fiorentina
del Signore, destinata a una circolazione più ampia,
rischiavano di non essere capiti in Italia, o fraintesi, sono
stati sostituiti con termini maggiormente generalizzati :
un uomo vestito in civile diventa in borghese, cinquantino
(foglio da cinquanta), cricchiare (scricchiolare); l'elvetismo
giorgetto, invece, può essere conservato in quanto
spiegato nel corpo stesso del testo: Cos'è il "giorgetto",
Baciccia ? - chiese questi all'uomo. - Lo schioppo, Ninetto
! - rispose quello, - e lo zaino, e i pacchetti dell'amante
o della mamma. D'altra parte, evidenti ragioni mimetiche portano
l'autore a mantenere nel discorso diretto certe espressioni
che per un non dialettofono continuano a suonare quando meno
ambigue : tutto il movimento, tutto il bazar; per esprimere
un "tutto" iperbolizzato, oppure le baracche per
"Le cianfrusaglie", socio per "amico"
e segare l'erba per "falciare". Rarissimo il dialettalismo
crudo, alla Gadda: abbiamo trovato soltanto cala per "spazzaneve"
al posto, eventualmente, di "calla" (che è
ticinesismo di uso burocratico), mentre galuppo ricalca adattandola
la forma originaria di galupp "ragazzone", registrato
anche nel lessico di Arbedo di Vittore Pellandini. Analogamente
adattati a partire dalla più schietta matrice dialettale
e persistenti sono besenfio ("gonfio"), soturno
("taciturno, cupo, malinconico") e modi di dire
pure molto caratteristici, del tipo fuori per settimana ("durante
la settimana"). Per il Ragno di sera, Calgari aveva registrato
casi ancora più flagranti: braccia piene di gnocchi
("contusioni") o far figura di ballabiotti ("mascalzoni").
Meno vistosamente ma significativamente, ancora nel Signore
: a sottoprezzo, parallelo al diffusissimo "a gratis"
dovuto a fraintendimento, viene raddrizzato facilmente dal
Filippini revisore di sé stesso, sopprimendo la preposizione;
allo stesso modo, a carponi è regolarizzato in carponi,
poco a poco, in a poco a poco. Tuttavia, dalle profondità
più riposte del sistema continuano ad emergere tratti
distintivi dei più notevoli. Il dialetto, come è
noto, è anche "lingua della realtà"
e le sue strutture, quando pur dispongano di alternative,
rifuggono tendenzialmente dalle formulazioni astratte, preferendo
quelle che pongano in primo piano l'elemento concreto, o che
siano di uso più corrente. Perciò (ma sono soltanto
pochi esempi): di sabbia, piuttosto che sabbioso; di musica
piuttosto che musicale, da morto piuttosto che mortuario,
in vergogna piuttosto che vergognoso. Per questi casi precisi,
l'autore, dopo aver primitivamente e spontaneamente messo
la forma più vicina alla parlata locale, ne ha poi
ritoccato l'assetto nella direzione opposta: oggi, in sostituzione
delle forme perifrastiche leggiamo precisamente, anche se
non proprio sistematicamente sabbioso, musicale, mortuario
e vergognoso. I ritocchi nelll'uso del participio in funzione
avverbiale confermano pure questa tendenza: si avvicinò
alla stufa goffamente era stato formulato in un primo tempo
si avvicinò alla stufa goffo, che è un modo
tipicamente "dialettale" per sottrarsi all'astrattezza
dell'avverbio in-mente, poi riassorbito nel sistema della
versione definitiva; per lo stesso motivo, averne abbastanza
ho potuto scriversi, all'origine, nella forma più "ticinese"
averne a basta.
Sulla base di questi pochi esempi,
abbiamo inteso dare un ritratto organico della tavolozza verbale
di Felice Filipini: certi che, anche al di là del loro
significato puntuale e delle dinamiche estetiche che le governano,
le correzioni dell'autore illustrano con didattica evidenza
anche molti caratteri profondamente iscritti nella coscienza
linguistica di noi ticinesi.
Guido Pedrojetta, Università
di Friburgo
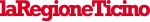
29.01.00
Page créée
le 01.08.98
Dernière mise à jour le 12.09.05

|

