|
Stefano Raimondi
Stefano Raimondi, La città dell’orto,
Prefazione di Umberto Fiori, Bellinzona, Casagrande, 2002
 Version imprimable
Version imprimable
| Stefano
Raimondi / La città
dell'orto |

ISBN 88-7713-377-5
|
|
"Ciò che noi facciamo
e pensiamo è colmo dell'essere dei padri",
quei padri contro cui l'Io conduce "una silenziosa
battaglia". Sono parole di Walter Benjamin poste
in esergo al poema che Stefano Raimondi dà
finalmente alle stampe nella sua interezza, dopo varie
anticipazioni su riviste o nel corso di pubbliche
letture. Le parole di Benjamin ci conducono al nòcciolo
di quello che Milo De Angelis in Poesia
contemporanea ha definito un "requiem"
dal tono "solenne e ispirato". È
il padre, infatti, il vero interlocutore - visibile
e invisibile - di questo libro, un padre che non è
soltanto privato ma anche pubblico e che sin dal titolo
si incarna nei muri, nei giardini e nelle voci di
una città. Per questo, come scrive Umberto
Fiori nella prefazione, il libro di Raimondi è
anche "un dolente amoroso lai indirizzato a un
"costato di calcine", alla "città
di sale", alla Milano "malabolgia"
e "paradiso delle cantine", alla cità
delle guardiole, dei tombini come bocche serrate dal
ghiaccio, dei cortili dove si raduna una "tiepida
stellata"".
|
|
|
Stefano Raimondi è
nato a Milano nel 1964. Laureato in filosofia. Ha pubblicato
Invernale (Lietocollelibri, 1999),
Una lettura d'anni in Poesia
contemporanea, a cura di Franco Buffoni (Marcos y
Marcos, 2001). Sue poesie sono appparse su "Nuovi Argomenti",
"Idra", "Atelier". Gli interventi critici
su riviste e in volumi collettanei hanno trattato autori
come Philippe Jaccottet, Yves Bonnefoy, René Char,
Paul Celan, Nelly Sachs e il pittore Nicolas de Staël.
È inoltre autore della monografia critica La
"Frontiera" di Vittorio Sereni (Unicopli,
2000) e curatore del volume Poesia
@... Luoghi Esposizioni Connessioni (Cuem Edizioni,
2002). Collabora a "Poesia" e "Pulp Libri".
È tra i fondatori della rivista "Materiali di
Estetica".
Stefano Raimondi,
La città dell’orto, Prefazione di Umberto Fiori,
Bellinzona, Casagrande, 2002
|
|
| Stefano
Raimondi, quando la poesia ci accompagna |
Nell’introdurre i due volumi
di una sua recente antologia della Poesia italiana del Novecento
(Carocci, 2002) – antologia con qualche mira normativa
di troppo e chiari intenti pedagogici – Niva Lorenzini
teme il peggio per le nuove generazioni poetiche: “I
rischi di un neoermetismo di ritorno – di foggia nuovissima,
dai nuovi manierismi formali alla riproposta della separatezza
di una poesia intesa a contemplare il proprio ombelico –
si intravedono tutti, e sono favoriti da una società
che predilige le omologazioni e gli appiattimenti, e tollera
a fatica il dissenso, la conflittualità, la presa
di coscienza, il coraggio delle opinioni”. Ci
si prospetta quindi un quadro a tinte fosche.
Eppure, se si avesse il coraggio
di abbandonare quel retrogusto marxiano che vuole la letteratura
procedere per scatti e capovolgimenti e la contemporaneità
dissugarsi nella volontà di sorpassamento costante,
a noi pare che una nuova generazione di poeti– e parliamo
specificamente dell’Italia – abbia davanti a sé
lo spazio di una sfida ben più stimolante dell’idea
di “fondare” una corrente. Non certo quella di
concentrarsi sull’ombelico del proprio ego liricheggiante,
quanto quello di ritornare all’umanità –
per quanto possa sembrare banale dirlo - al bisogno di dire
come essere umano, cui sta di fronte un lettore a sua volta
alla ricerca dell’incontro. Fino al capovolgimento
positivo, propositivo, di questo rapporto.
“Questo
mi spinge a ritenere – scrive Fabio Pusterla
– che il criterio della
necessità, che io stesso adotto in quanto lettore,
non riguardi tanto il rapporto tra testo e autore (era il
poeta fortemente motivato a scrivere ciò che ha scritto?
Ne aveva assoluta necessità? Non lo sapremo mai con
certezza, vivaddio!), quanto piuttosto l’altro rapporto,
che quel testo stabilisce con quel lettore che io sono.
Mi è necessario, ciò che leggo? Mi urge leggerlo?
E se le cose stanno così: è possibile credere
che la poesia conservi oggi, nella sua condizione di esilio,
una necessità siffatta? Che qualcuno (qualche lettore)
chieda ancora qualcosa alla poesia? Che si possano dunque
intravedere delle piste su cui alla poesia sarebbe consigliabile
incamminarsi?”.
Di fronte al commovente libro del
milanese Stefano Raimondi La
città dell’orto (pubblicato da Casagrande
a Bellinzona, con una meritevole apertura al di là
del confine), si ha l’impressione che il poeta –
compiendo in poesia un doloroso scavo sulla propria esistenza
di figlio, nel dasein
di una città che gli è trasmessa dal padre
– voglia proprio condurci in questa direzione, fare
un tratto di strada per noi, essere onesto (come voleva
Saba), perché un cammino si disegni davanti ai nostri
passi stanchi. Stanchi di un mondo automatizzato dalle leggi
del Management, di una
città disfatta da una sporcizia planetaria, capace
di corrompere il nostro stesso modo di percepire la realtà.
I suoi occhi nuovi non sono né illusi né disillusi,
non sono moralisti, non ci insegnano niente se non forse
a vivere laddove la poesia ridiventa la “sorella
maggiore dell’azione” (Saint-John-Perse).
Il volume è introdotto da
Umberto Fiori: apertura sintomatica che segna al contempo
una continuità e uno sviluppo. Si prenda l’ultimo
volume di versi di Fiori (La bella vista, Marcos y Marcos,
2002): il poeta vi interroga la bellezza del paesaggio,
si lascia mettere in scacco – fino alle ultime conseguenze
– dalla “straziante,
meravigliosa bellezza del creato” (è
una frase di Totò, in un film sublime di Pasolini).
Ma se in Fiori quest’interrogazione umanissima non
può farsi senza una preoccupazione intellettuale
(che lo accomuna a certe geometrie della percezione di Valerio
Magrelli o al civismo di Antonella Anedda), in Raimondi
la commozione del mondo è polarizzata intorno al
sentire personale (non l’ombelico, no, semmai il Naked
thinking heart di Donne!). La sovrapposizione tra
biografia e topografia accomuna piuttosto Raimondi ai coetanei
(Antonio Riccardi, oppure – ma in una versione ben
più “cantabile” – Claudio Damiani),
mentre l’attenzione al rapporto tra corpo e linguaggio
s’avvicina a esperienze come quelle di Matteo Ceserani
o Elisa Biagini:
come ciechi tastiamo le cose
gli amori e le persone:
diciamo di volerci bene.
Tocchiamo tutto come qualcuno
che dall’altra parte afferra
qualcosa e la rivuole. (p. 74)
Come si vede, con un linguaggio piano,
retaggio di una generazione cresciuta con l’orizzonte
semantico di un italiano “nativo”, senza l’aporia
di una lingua letteraria inutilizzabile nel quotidiano (e
viceversa). La città, Milano, vero cardine (insieme
alla lenta agonia paterna) del libro di Raimondi, non può
più essere allora un luogo da trasfigurare poeticamente,
come una voce che cerca di trarre gli ultimi barbagli di
una mai rinnegata anceschiana “linea lombarda”
(si pensi a Maurizio Cucchi): la città diventa corpo
e respiro, sofferenza e viaggio, in cui si cerca lo sterrato
di un cortile, l’apertura rachitica di un orto, come
luoghi salvifici: “Ci sono
notti indolenti / notti che sembrano orti” (p.
32).
E il lettore non è più
convocato a una spettazione: aiutato dall’estremo pudore
biografico di Raimondi, dall’evocatività di
una lingua dalle trasparenze metaforiche, si trova invitato
sulla barca di carta spiegazzata di un’umanità-per-quello-che-è.
Senza narcisismo, senza che il poeta voglia porsi al di
sopra o al di là della propria umana vicenda. E questo
libro denso, aperto a una profondità senza ambizioni
pedagogiche, scioglie allora le sue vele al largo di una
prosa poetica (che è tutt’altro che una rinuncia
alla poesia, tutt’altro che prosa d’arte), che
il lettore potrà fare sua, come un golfino posato
sulle spalle, quando fa un po’ troppo freddo per proseguire
nell’inverno:
Ci sono notti per tutti, notti
testarde, notti spostate dalle stelle.
Lì si trovano gli indizi, le prime fila, le rotte
del bene. (p. 71).
Pierre Lepori
© Le Culturactif Suisse 2002
Stefano Raimondi, La città
dell’orto, Prefazione di Umberto Fiori, Bellinzona,
Casagrande, 2002
|
|
| Stefano Raimondi,
La città dell'orto |
Sono due le direttrici tematiche
che orientano la scrittura di Stefano Raimondi, entrambe
rintracciabili, mi pare, sin dai titoli delle sue due pubblicazioni
poetiche: Invernale s'intitolava
infatti una sua plaquette
del 1999, mentre questa sua complessa e poematica opera
prima è denominata La
città dell'orto. Come dire un tempo e un luogo,
dunque, ossia le coordinate trascendentali entro cui si
inscrive l'esperienza umana e lettararia dell'autore, e
che da questa ricevono la loro irripetibile determinazione.
In Raimondi il tempo è spesso l'inverno, stagione
altamente allegorica e decisiva per la poesia italiana degli
ultimi decenni (lo notava già Remo Pagnanelli in
un saggio dell'87), nonché centrale in alcuni dei
poeti europei evidentemente più cari a Raimondi (penso
a Paul Celan e a Philippe Jaccottet, autori di raccolte
consacrate all'inverno sin dal titolo: rispettivamente Schneepart
e À la lumiere
d'hiver); è un inverno gelido e onnipervasivo,
che "scende nella gola", e al quale spesso si
oppongono spazi chiusi e riparati, simbolicamente isomorfi:
le tasche in cui pigiano i pugni, le mandorle e le noci
sigillate, Le stanze chiuse
dall'inverno, titolo di un'intera sezione della terza
parte, eponima, della raccolta; per ciò che riguarda
lo spazio, invece, La città
dell'orto è senza dubbio Milano, città
natale dell'autore e sfondo insieme riconoscibile (la Vetra,
il Garibaldi, il ponte del Corvetto) e metafisico dei suoi
dialoghi col padre: è una Milano "malabolgia
[…] fatta a cerchio", spesso notturna, in cui
"le cose crescono serrate"; una città che
in realtà - l'ha già notato Fabio Pusterla
- sembra lasciare ben poco spazio a giardini ed orti, e
che tuttavia è percepita essa stessa come enorme
hortus conclusus ("Milano finisce qui") recintato
circolarmente dai viali. È in questo spazio, invernale/infernale
e vitale assieme, che si svolge la vicenda cardinale dell'agonia
e della morte del padre, le cui parole diventano costantemente
corpo vivo del testo, intimo impulso dialogico e drammatico.
"Se qualcosa ci ha uniti / è un'idea di città
e non altro - ", scrive Raimondi, quasi che la città
fosse un prolungamento del corpo in cui il figlio riconosce
l'impronta del padre, tanto che Sei
tu, per me, Milano è agnizione talmente decisiva
da assurgere a titolo di sezione. Così, col "fiato
rotto, [e] tanta pietà" da sorprendere se stesso
e il genitore morente ("così sottile e nudo,
così legato / tutto rannicchiato"), Raimondi
traccia col suo poema il cammino di metamorfosi del padre
in memoria ("Sono io, adesso, ad avere memoria")
e in parola: "Non sei che la mia preghiera. / La tua
carne è di fiato"; o altrove: "Sei la prima
parola chiara / che mi hai detto al mattino". È
proprio in virtù di tale metamorfosi ("…ti
curo come fossi il mio alfabeto") che il poeta può
accogliere e preservare, nella propria parola (quella scritta),
la presenza paterna, liberando nei versi tutta la sua pietas
di uomo e di figlio.
Massimo Gezzi
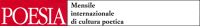
"Poesia", n. 169,
febbraio 2003
|
|
| Vi sono anche
gli orti |
|
Nel suo Elogio di Milano per
la sua fertilità e la sovrabbondanza di ogni bene
(che occupa per intero il quarto capitolo del De
magnalibus Mediolani) Bonvesin de la Riva osserva:
"Vi sono anche gli orti, che fioriscono per l'intero
corso dell'anno e producono abbondanza di legumi di ogni
genere". E forse Stefano Raimondi, ordinando le sue
poesie sotto il titolo La città
dell'orto, potrebbe strizzare l'occhio al suo grande
antenato duecentesco: benché gli orti, come tutti
le altre bellezze naturali elencate da Bonvesin (frutteti,
castagneti, dolcissime vigne, fertili fiumi e infiniti ruscelli
di fonte, ecc.ecc.), sembrino oggi del tutto estranei alla
realtà milanese. E proprio in questo senso, già
il titolo scelto dall'autore suggerisce una dolorosa antitesi,
che sarà poi sviluppata ed elaborata nel corso della
raccolta. L'argomento principale del volume, cioè
il tema della morte del padre, è infatti sin dall'inizio
inserito in una cornice metropolitana che complica e arricchisce
la meditazione poetica di Raimondi. Se l'orto
richiama una dimensione umana umile e familiare, una memoria
operaia di lavoro e di affetti che rimanda alla figura paterna,
l'altro termine città
parla invece della Milano odierna, frenetica e spietata,
malabolgia fatta a cerchio
in cui i destini individuali sembrano perdersi nel nulla
e svanire. Cos'è la morte, nella Milano contemporanea?
Quale spazio sa schiudere la città costato
di calcine alla pietà del dolore e del lutto,
alla dolcezza del ricordo e dei baci? E in che modo il transito
delle vite umane modifica e rifonda la stessa città,
passando il testimone della memoria dal padre al figlio
(ma in questo scambio, la memoria stessa non muta? e come?
"Sono io, adesso, ad avere memoria…", recita
uno dei versi più belli)? Sono questi, e altri di
analoga intensità, gli interrogativi che Raimondi
insegue nei suoi versi, entro i quali la vicenda biografica,
appena accennata con pudore, si intreccia e si fonde con
il paesaggio urbano, colto nei suoi rari momenti di apertura,
di squarcio in chiaroscuro: giardini, parchi, spiazzi, dove
per un istante le case si aprono, e le figure umane si rivelano
nella loro precaria individualità, nel loro divenire
tormentato, più purgatoriale che infernale ( le Ombre
che vanno di Purg. XXIII, per esempio; ma il canto
VIII della stessa cantica è esplicitamente rammentato
in uno dei testi finali del libro, che cita per esteso l'Inno
della Compieta) . Uno degli aspetti più interessanti
del libro risiede appunto in questa sovrapposizione drammatica,
che si manifesta soprattutto nelle parole e nelle immagini:
come se un lessico cittadino pietroso, secco e scarno, fosse
centrifugato insieme al vocabolario pietoso dei sentimenti,
alle formule quasi liturgiche del compianto funebre. Per
questa via, ecco generarsi ora una lacerazione semantica
("per restare fatti / di pietà e di pietra ";
"Ghiaccio sui tombini come sopra bocche"; "Da
qui non s'indovinano i perdoni. / Solo la luce rasa tiene
/ il conto dei tetti risparmiati, / delle cantine tenute
premute / con il buio bendato alle porte / rifugiato dentro"),
ora una sorta di misteriosa fusione ("La pietra ora
è nel mio sangue. / Non so chi di noi due è
più solo / chi forte e d'ora in poi / per sempre";
"Un'ombra fa più alta la casa / e dentro è
un cortile che tace tutto /anche l'ultimo piano che si sbraccia";
"Tienile al buio le mie parole. / Hanno ancora un'ombra
/ una sola città dove farsi capire") che sembra
poter trasformare anche il dolore in una luce commossa:
sicché, nella poesia conclusiva, ma anche in molte
altre parti della raccolta, "Tremano anche le stelle:
brillano".
Fabio Pusterla

17.09.2002
Page créée le 01.11.02
Dernière mise à jour le 01.11.02

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|